Ieri sera, mentre stavo chiudendo il computer dopo un’altra giornata passata a leggere notizie che sembrano annunciare la fine del mondo (lo so, dovrei smettere, ma è più forte di me), mi è tornata in mente una frase che avevo letto tempo fa. Credo fosse di Mark Twain, o almeno così mi piace pensare: “La storia non si ripete, ma fa rima”. O forse era “rime”? Non sono sicuro, ma il punto è che il concetto mi ha colpito. Non trovi che sia geniale?
La cosa divertente è che me la ricordo perché l’avevo scritta su un post-it e attaccata al monitor. Quel post-it è rimasto lì per mesi, fino a quando non si è scolorito e ha iniziato a penzolare tristemente da un angolo. Ma la frase mi è rimasta impressa, soprattutto in questo periodo dove sembra che ogni giorno porti una nuova catastrofe annunciata.
Penso spesso a com’è andata con la stampa di Gutenberg. Cioè, immaginate di essere un monaco amanuense nel 1450. Hai passato la vita a copiare manoscritti, sei diventato bravissimo, i tuoi colleghi ti rispettano. E un bel giorno arriva questo tizio tedesco con una macchina che stampa libri a centinaia. Dev’essere stato come quando oggi un grafico scopre che l’AI fa in cinque minuti quello che lui ci mette una giornata.
La differenza sta nel fatto che noi, con il senno di poi, sappiamo come sono andate le cose. La stampa non ha distrutto la cultura, anzi l’ha fatta esplodere in mille direzioni. Ha aperto porte che prima erano chiuse, ha creato nuovi mestieri, reso i libri accessibili a chiunque e, in sostanza, ha trasformato il mondo in meglio. Certo, posso immaginare che per i poveri monaci amanuensi del tempo non fosse così facile vedere il lato positivo.
Quando la storia ci fa l’occhiolino (e noi non ce ne accorgiamo)
Contents

Anni addietro, non diciamo quanti, mi sono ritrovato a visitare Pompei con la classe delle medie. C’era, lo ricordo come se fosse ora, una mia compagna di classe concentrata sul Vesuvio, curiosa di vedere il vulcano con i suoi occhi, mentre io non vedevo l’ora di perdermi tra le rovine.
C’era un graffito che mi ha fatto ridere. Tradotto suonava tipo “Marco è stato qui ed è figo”. Duemila anni dopo e la gente scrive ancora le stesse cose sui muri. Okay, ora lo fanno su Instagram, ma il concetto non è cambiato. Quella voglia di dire “io esisto, ricordatevi di me” è sempre uguale.
Poi c’era quest’altro, più romantico: “Qui Marco ha amato Giulia”. E lì mi è venuto un po’ di magone, lo ammetto. Perché Marco e Giulia sono morti da un pezzo, ma il loro amore è ancora lì. È una cosa che mi ha fatto pensare a quanto siamo piccoli nella grande storia, ma anche a quanto siamo importanti per chi ci sta vicino.
Durante il Covid ho riletto “Diario dell’anno della peste” di Daniel Defoe. L’avevo studiato all’università senza capirci granché, ma nel 2020 ogni riga mi sembrava scritta il giorno prima. La gente che si ammala, i complottisti che negano tutto, gli esperti che litigano tra loro, la borsa nera delle mascherine. Uguale identico. Solo che invece del 1665 era il 2020 e invece di Londra c’era il mondo intero.
Mi sono chiesto perché nessuno ci aveva pensato prima. Cioè, le pandemie sono sempre esistite, potevamo studiarle meglio. Ma no, abbiamo dovuto rifare tutti gli stessi errori. “L’esperienza è quella cosa che acquisti subito dopo che ti sarebbe servita”.
Nassim Taleb (quello del “Cigno nero” – libro tosto, ma ne vale la pena) dice che sottovalutiamo sempre gli eventi rari. Però non sono poi così rari se guardi la storia. È che noi viviamo in bolle temporali di 70-80 anni e ci dimentichiamo tutto quello che è successo prima.
Come non farsi fregare dal futuro (spoiler: usando il passato)
Allora, la domanda è: si può usare tutto questo casino del passato per capire dove stiamo andando? Secondo me sì, ma non nel senso di prevedere il futuro come una cartomante. Più nel senso di non farsi prendere dal panico ogni volta che cambia qualcosa.
Prendiamo l’intelligenza artificiale. Tutti terrorizzati che ci ruberà il lavoro. Può darsi, eh. Ma ogni volta che è arrivata una nuova tecnologia c’è stato il panico. Socrate era convinto che la scrittura avrebbe rovinato la memoria (e aveva pure ragione, in parte – chi si ricorda più i numeri di telefono?). I giornali dell’800 erano pieni di articoli sui pericoli della ferrovia: “Viaggiare a quella velocità farà esplodere il corpo umano!”. Negli anni ’50 la TV avrebbe trasformato i bambini in zombie.
Non è che tutte le paure siano infondate. È che spesso ci concentriamo sui rischi sbagliati e ignoriamo le opportunità. La mia amica Lisa, che fa la traduttrice, invece di lamentarsi di ChatGPT ha imparato a usarlo per velocizzare il lavoro di routine e concentrarsi su quello più creativo. Furba.
Rebecca Solnit (ha scritto “Speranza nel buio”, libro che ho scoperto durante uno dei miei momenti “il mondo va a rotoli”) dice una cosa bella: “Il futuro è buio, nel senso migliore del termine”. Buio significa sconosciuto, e sconosciuto significa pieno di possibilità. Non è che mi fa saltare dalla gioia l’incertezza, ma è meglio di un futuro già scritto e deprimente.
Una cosa che mi ha sempre colpito studiando storia è che le soluzioni migliori vengono spesso da posti inaspettati. Il velcro nasce perché un tizio guarda come i semi si attaccano al pelo del cane. La penicillina è un incidente di laboratorio, ma in una mente preparata. Il web nasce per far comunicare i fisici e diventa… beh, questo casino che conosciamo.
Il punto è che il futuro non è una cosa che ci capita. Lo facciamo noi, un pezzo alla volta, con le nostre scelte. E le scelte migliori le fa chi ha imparato qualcosa dal passato. Come diceva Churchill (o forse era qualcun altro, ma glielo attribuiamo lo stesso): “Più lontano guardi nel passato, più lontano vedi nel futuro”… O qualcosa del genere.
Libri che mi hanno fatto ragionare (e dove li ho trovati)
Se volete continuare a ragionare su questi temi, vi consiglio il blog di Farnam Street Think better. Decide better. Live better. . Shane Parrish scrive cose sensate su come pensare meglio, senza la puzza sotto il naso di certi intellettuali. Poi c’è Our World in Data Our World in Data che mette in prospettiva storica un sacco di cose che ci sembrano drammatiche oggi ma che in realtà stanno migliorando da decenni.rmente.
- “Sapiens” di Harari l’ho comprato per caso in aeroporto. Avevo finito di leggere il giornale e mi annoiavo. È finita che non ho chiuso occhio per tutto il volo, troppo preso dalla storia dell’umanità raccontata come un romanzo d’avventura. Harari ha questo modo di prendere cose che credevi di sapere e rovesciarle completamente.
- “Il cigno nero” di Taleb l’ho letto dopo la crisi del 2008, quando tutti dicevano “nessuno poteva prevederlo”. Taleb invece spiegava esattamente perché queste cose succedono regolarmente e perché continuiamo a farci sorprendere. È un libro antipatico nel senso migliore: ti fa arrabbiare perché ha ragione.
- “Diario dell’anno della peste” di Defoe l’ho riscoperto durante il lockdown. L’avevo odiato a scuola, troppo lungo e noioso. Riletto nel 2020 mi sembrava contemporaneo. Evidentemente a 18 anni ero troppo giovane per apprezzare certe cose, o forse serviva una pandemia vera per capirlo.
- “Speranza nel buio” della Solnit l’ho trovato citato in un articolo del Guardian. Era uno di quei giorni in cui leggere le notizie ti fa venire voglia di andare a vivere su un’isola deserta. Lei riesce a trovare motivi di ottimismo anche nelle situazioni più nere, senza sembrare una di quei guru della positività tossica.
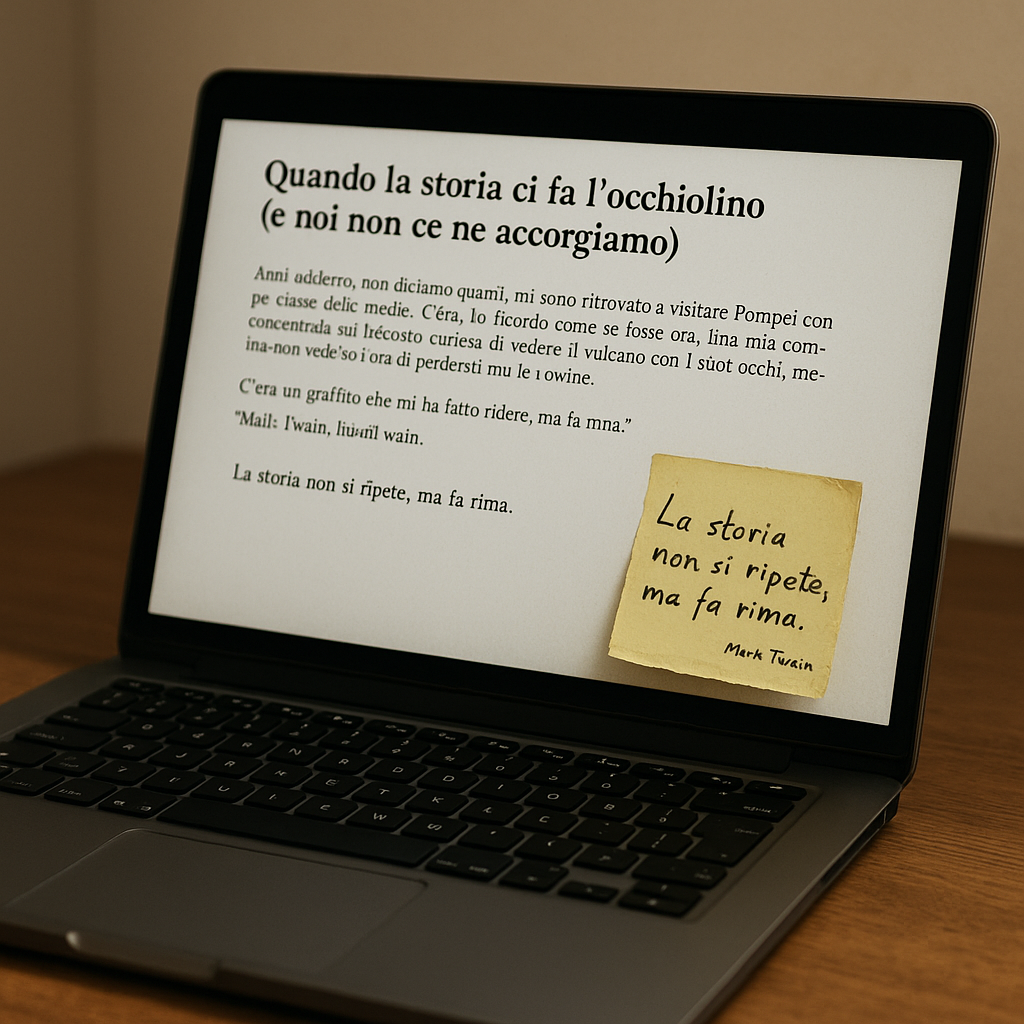
No responses yet